Giuseppe Lippi ci accompagna nella conoscenza di Walter S. Tevis e dell’Urania Collezione che arriva in edicola in questi giorni: Futuro in trance.
 Walter S. Tevis – un professore di università dell’Ohio, come il Bentley di questo romanzo – è noto ai lettori di fantascienza per un paio di opere, non di più: L’uomo che cadde sulla Terra (1963), il romanzo portato sullo schermo da Nicolas Roeg, e A pochi passi dal sole, un romanzo del 1983. In mezzo sta questo Mockingbird (1980) che in Italia è apparso anche con il titolo Solo il mimo canta al limitare del bosco. Tuttavia ha pubblicato diversi racconti brevi – facendo il suo esordio nel genere su “Galaxy”, nel 1957 – e una raccolta che li traduce in italiano è Lontano da casa, in “Urania” n. 1162. Gli appassionati di cinema lo ricordano per aver fornito il soggetto de Lo spaccone di Robert Rossen (1961), l’amaro film interpretato da Paul Newman e George C. Scott tratto dal suo romanzo.
Walter S. Tevis – un professore di università dell’Ohio, come il Bentley di questo romanzo – è noto ai lettori di fantascienza per un paio di opere, non di più: L’uomo che cadde sulla Terra (1963), il romanzo portato sullo schermo da Nicolas Roeg, e A pochi passi dal sole, un romanzo del 1983. In mezzo sta questo Mockingbird (1980) che in Italia è apparso anche con il titolo Solo il mimo canta al limitare del bosco. Tuttavia ha pubblicato diversi racconti brevi – facendo il suo esordio nel genere su “Galaxy”, nel 1957 – e una raccolta che li traduce in italiano è Lontano da casa, in “Urania” n. 1162. Gli appassionati di cinema lo ricordano per aver fornito il soggetto de Lo spaccone di Robert Rossen (1961), l’amaro film interpretato da Paul Newman e George C. Scott tratto dal suo romanzo.
L’uomo che cadde sulla Terra si era già segnalato per l’ambiguo e affascinante tratteggio del protagonista, un extraterrestre potentissimo ma “fragile”; l’uscita nel 1980 di Mockingbird, il romanzo che qui si presenta, conferma in Tevis un ottimo narratore, uno dei più sensibili su cui possa contare la fantascienza americana. Il libro, diciamolo subito, ci sembra felicemente estraneo agli abituali canoni fantascientifici e s’inserisce nel panorama con un’autorità tutta propria, perfino un po’ anomala. È un’utopia dalla non comune forza visionaria; è forse uno dei pochi romanzi “psicologici” (vedremo che il termine ha un senso più ampio) che valga la pena di leggere ancora e che la fantascienza abbia prodotto.
Mockingbird è costruito su uno sfondo da utopia negativa, ma la sua natura è piuttosto quella dello psicodramma. Siamo di tre o quattro secoli nel futuro, dopo la prevedibile Morte del Petrolio, dopo l’Incidente di Denver e altre complicazioni; ma tutto questo è brusio sullo sfondo e viene a galla lentamente, attraverso i dialoghi dei personaggi e le loro considerazioni. I personaggi principali sono tre: Spofforth, il robot Serie Nove, Bentley (il professore dell’Ohio) e una ragazza strana ed enigmatica di nome Mary Lou.
Mary Lou dorme al giardino zoologico, davanti alla gabbia di un serpente (che non è un serpente, ma solo un’imitazione meccanica). Si sottrae alle pillole condizionanti da cui dipende la pace nervosa dell’umanità, non lavora: ruba i sandwich dalla macchina distributrice approfittando che il robot-fornitore è troppo stupido per accorgersene. È inquieta ed è simile a un risvegliato in un paese di sonnambuli.
Bentley per qualche verso le assomiglia: è un uomo che sa leggere (nessuno sa leggere in questo mondo, nemmeno i robot più perfezionati; alle università si insegnano tecniche di “rilassamento” e “sviluppo interiore”, non letteratura o scienza); è un sentimentale, uno che scopre – attraverso l’esperienza della lettura, del cinema muto e poi della prigione – di desiderare l’amore e la comunicazione come opposto all’isolamento dei sogni autistici. (La professione di Bentley consiste nell’insegnare ai giovani l’arte di produrre e controllare certe visioni psichedeliche, e la cosa è interessante se si tien conto che in seguito svilupperà un amore profondo per la letteratura e per tutto ciò che è conoscenza. La conoscenza, in altre parole, deve sempre metterci in rapporto con il mondo, non spingerci a rifuggire da esso. Dopo aver imparato a leggere, Bentley balza a una nuova coscienza di sé e del prossimo, e Tevis pone il problema sia in termini di comunicazione che in termini di salute morale).
Il terzo personaggio è Spofforth, il robot Serie Nove, il demiurgo di questo mondo in decadenza (non giureremmo che sia l’unico, ma certo è uno dei pochi androidi “di colore” della fantascienza). Spofforth è immortale, è quasi onnisciente: pure, una delle prime cose che ha imparato a desiderare è la morte. Non è uno di quegli irritanti robopatetici che a tutti i costi vogliono sangue invece che olio, nelle vene: lui probabilmente il sangue ce l’ha, è stato clonato da tessuto vivente. È l’incarnazione, plausibile e convincente, del desiderio di morte non solo individuale, ma di un’intera specie. Forse i robot sono la personificazione di quelle che gli psicologi chiamano “proiezioni”: su Spofforth il genere umano ha “proiettato” il suo disamore per se stesso, costruendosi un feticcio da venerare e odiare.
Il mondo in cui vivono Bentley, Mary Lou e Spofforth è un mondo senza storia. “Da bambino” scrive a un certo punto Bentley “mi hanno insegnato che prima della Seconda Era tutte le cose erano violente e distruttive perché nessuno rispettava i diritti umani, ma niente di più specifico. Non abbiamo mai sviluppato un vero e proprio senso della storia; tutto quel che sapevamo, sempre che ci soffermassimo a riflettere, era che prima di noi c’erano stati gli altri e che noi eravamo migliori di loro. Ma nessuno veniva mai incoraggiato a pensare al mondo esterno.”
“Non fare domande: rilassati”: è questo il comandamento del mondo senza storia. Tevis potrebbe fare sue le dichiarazioni del regista inglese John Boorman, rese parecchi anni fa: “In America c’è l’inquietante tendenza a non tener conto della storia, nemmeno la più recente. L’americano medio non si pone domande sulla scatoletta che ha appena comprato al supermercato, e io trovo che sia pericoloso esser tagliati fuori dalle fonti di ciò che usiamo e consumiamo. È sano interrogarsi sull’origine delle cose”. Ma per interrogarsi bisogna fare una scelta e accettare delle responsabilità.
“Non fare domande: rilassati” diventa il suggerimento che permette di evitarle. Molto di più: diventa la parola d’ordine di un vero e proprio condizionamento. Ora, la fantascienza ci ha abituati in varia misura alle società totali e condizionanti: ma questa di Tevis s’impone perché è essa stessa un’immagine della psiche, e il suo prodotto è un essere umano trasformato.
Pochi romanzi sono altrettanto visionari nell’immaginare una razza che, rinunciando a ogni funzione vitale, si è murata nel proprio egocentrismo e si è votata così all’estinzione. Trionfa il mito della self-reliance, l’autosufficienza, che sconfina in ottuso egoismo da una parte e in schiavitù dall’altra. L’umanità dei giorni di Bentley, infatti, è schiava. E non solo dei robot e delle pratiche di self-fulfilment, ma di se stessa.
Quello che colpisce in questo bel romanzo, man mano che si procede, è che il “caso clinico” di cui è vittima la razza potrebbe corrispondere benissimo a quello di un sol paziente: ne emerge il ritratto di una nevrosi che è reale sia sul piano collettivo sia su quello individuale. Affidatasi all’inorganico (macchine, droghe sintetiche) la razza può proteggere la sua parvenza di vita solo a prezzo dell’ignoranza: e infatti insegnare a leggere è vietato, parlare agli altri per più di qualche minuto è vietato, convivere è vietato. Questo rifiuto della realtà è un rifiuto della responsabilità, ed è l’equivalente dell’autoinganno a cui si sottopone il nevrotico per proteggere la sua particolare costruzione difensiva.
Gli autoinganni immaginati da Tevis a livello sociale sono numerosi: il principale obiettivo da raggiungere è la inwardness, o “crescita verso l’interiorità”; questo mito maschera in realtà la paura di comunicare, e infatti i contatti umani sono ridotti a zero (il più stretto, prevedibilmente, è il “sesso veloce” che si fa in condizioni di stupore). Per raggiungere questo affinamento dell’introversione, che è una parodia dello sviluppo interiore autentico, è necessaria la solitudine: ma nel mondo di Bentley le cose non vengono mai chiamate col loro nome, sicché il comandamento di star soli viene mascherato dietro il mito della privacy. Abolita la famiglia, i pochissimi bambini sono allevati in appositi dormitori dove vien loro insegnato a “stare insieme per ignorarsi”. È un esercizio fondamentale, nelle scuole di questo mondo: si riempie una stanza di ragazzini e li si condiziona a dimenticare l’esistenza degli altri. È un’esperienza importante, che da adulti sfocerà nel fenomeno del privacy withdrawal (il ritiro nella privacy, manifestazione automatica di difesa che scatta se un altro individuo ci parla per più di un minuto o se ci rivolge una specifica domanda, fatto imbarazzante oltre che sempre perseguibile).
D’altra parte, la facciata dietro cui cova questa morte dello spirito va salvata: ecco dunque l’altro comandamento, quello della mandatory politeness, la cortesia obbligatoria, a ricordare – se ce ne fosse bisogno – che la vita psichica del singolo e della comunità è regolata da una serie di dettami coattivi. Come in molte nevrosi, la cortesia obbligatoria ha lo scopo di porre i rapporti su un piano idealizzato e rispecchia la fondamentale scissione del soggetto.
Una celebre psicanalista americana, Karen Horney, ha paragonato la nevrosi a un patto col diavolo: è una maniera mitica per visualizzare il problema, e ci pare particolarmente adatta su un terreno – come quello della fantascienza – che fa ricorso volentieri a termini mitici. Ma chi è il “diavolo” della situazione? Forse Spofforth, il super-automa? Crediamo proprio di no: il diavolo resta il diavolo, e Spofforth è al massimo la conseguenza dei suoi servigi, che portano al disamore e quindi all’estinzione. Ma i termini del paragone reggono: stipulato il patto per liberarsi della responsabilità, la razza umana deve rinunciare al senso della realtà e alle sue stesse funzioni vitali.
Perché non nascono più bambini, nel mondo di Bentley e Mary Lou? Perché nessuno osa reggere lo sguardo degli altri? Perché lo “sviluppo interiore” culmina, per molti, nell’orrenda pratica di darsi fuoco vivi?
Il libro di Tevis, tuttavia, non è un sermone: e non vorremmo averne dato qui l’impressione, anticipando alcuni motivi e alcuni argomenti con troppa enfasi. È un romanzo costruito con scioltezza, dalla scrittura elegante e mossa, che tocca momenti intensamente lirici. È un romanzo che affronta con levità uno dei veri motivi di declino della nostra civiltà, e riesce a trarne un quadro agile e realistico. Il motivo in questione è il “ritiro”, il ritiro della mente in una para-realtà e in una rete di para-comunicazioni che sono menzognere, che defraudano in umanità la specie.
Tutto è cominciato con l’automobile, osserva ironicamente Tevis, che in essa vede una monade impenetrabile. Poi è venuta la televisione, e infine le droghe: oggi si potrebbero aggiungere i personal computer, ma il discorso non cambia. Il processo di alienazione consiste nel distacco dal mondo e dal vero sé.
Tuttavia, persino nella nevrosi esiste un dualismo che può portare il paziente a emergerne e a guarire: l’attaccamento alla propria identità e l’amore sono le armi più efficaci. Bentley, umanisticamente, è “l’uomo risanato” per via intellettuale oltre che emotiva, e alla fine del romanzo osserva nel suo diario:
Ripensandoci, ora, capisco che non ho più paura di Spofforth, né della prigione, né di alcun impedimento, e nemmeno di profanare la privacy di chicchessia. E ora, mentre procedo sulle antiche autostrade verdi cosparse di buche, con l’oceano alla destra e i campi vuoti alla sinistra, sotto il luminoso sole primaverile, mi sento libero e forte. Se non avessi letto dei libri, non potrei sentirmi così. Qualsiasi cosa mi succeda, grazie a Dio, so leggere, e ho veramente preso contatto con la mente di altre persone. Vorrei tanto poter scrivere queste parole, invece di dettarle. Perché scrivendo, oltre che leggendo, ho trovato il senso del mio nuovo io.
E poco più avanti:
Avere la mia Privacy e la mia Auto-sufficienza e la mia Libertà: cosa contava, se mi sentivo così? Ero in uno stato di “struggimento”, e lo ero da anni. Non ero felice… Non lo ero quasi mai stato… Quel che avevo desiderato e voluto anche allora era essere amato. E amare. E loro non mi avevano nemmeno insegnato la parola.
La scoperta dell’amore porta alla guarigione; la sua mancanza, o la sua impossibilità, porta alla morte: questo spiega il destino di Spofforth. E proprio il robot, che per ragioni biologiche ne è escluso, ne dà una delle immagini più toccanti. “Che cosa intendi, tu, per amore?” gli domanda Mary Lou.
Aspettò a lungo prima di rispondermi. Poi disse: “Un senso di agitazione nel petto. Palpitazioni. Il desiderio che tu sia felice. Un’ossessione di te, il piacere di guardarti piegare il mento, di scrutare lo sguardo intenso dei tuoi occhi. Ammirazione per il modo in cui tieni quella tazzina di caffè. Il sentirti russare, la notte, mentre io sono sveglio”.
Così dicendo, Spofforth rivela la centralità dell’amore. Nella sua imperfetta capacità di viverlo sta il suo interesse come personaggio, oltre che come specchio e come fantasma. Quando parla d’amore, tuttavia, Tevis non intende solo quello romantico, ma in genere l’amore per la vita e per la continuazione della specie. Il romanzo è la storia di una guarigione individuale – quella di Bentley e Mary Lou –, di una guarigione collettiva e della distruzione di un feticcio ossessivo. Per questo, in apertura, l’abbiamo definito “psicodramma”; ma la lettura dimostrerà che Tevis è più sottile, sfumato e acuto di quanto qui si sia riusciti a dire.
E nel romanzo, limpido e fluente, parola viene dietro parola come una benedizione.
Giuseppe Lippi
La bibliografia italiana è reperibile sul Catalogo SF, Fantasy e Horror a cura di Ernesto Vegetti.
 1943: chiude la rivista di John W. Campbell “Unknown Worlds”. 1949: Anthony Boucher, che ne era stato un attivo collaboratore, fonda insieme a J. Francis McComas una nuova testata che possa prenderne il posto e pubblicare, almeno in parte, lo stesso genere di materiale sofisticato sia nel campo della narrativa fantastica che della fantascienza; una rivista non più ritagliata nel classico formato pulp e che si rivolga ad un pubblico preparato, capace di recepire la science fiction moderna aperta alle suggestioni del mito. Il nuovo periodico, di formato digest o semi-tascabile, si intitola semplicemente “The Magazine of Fantasy”, anche se a partire dal secondo numero la testata verrà modificata in “The Magazine of Fantasy and Science Fiction”. Nel 2009 questa celebre pubblicazione americana – cui anche “Urania” deve molto, avendo attinto per anni ai suoi forzieri – ha festeggiato i sessant’anni di ininterrotta attività sotto la guida di Gordon Van Gelder. Boucher, il suo fondatore, l’aveva creata tenendo presenti due modelli: uno, come abbiamogià visto, è quello di “Unknown Worlds”, rivista in cui il fantastico non era mai gratuito né orripilante, ma rigoroso e vicino in spirito alla sf; l’altro è rappesentato da una pubblicazione gialla, la “Ellery Queen’s Mystery Magazine” (EQMM) che Frederic Dannay e Manfred B. Lee, i cugini Queen, avevano fondato per l’editore Mercury nel 1941. L’intento dei Queen era stato quello di creare una vetrina per il racconto giallo che non seguisse la moda della pulp fiction, ma permettesse ai migliori scrittori del poliziesco di trovare il proprio mercato anche al di fuori dell’indirizzo hardboiled. E così Rex Stout, Cornell Woolrich, John Dickson Carr e gli stessi Queen avevano potuto contare su uno sbocco nuovo e sofisticato, al quale ben presto si sarebbero accodati anche alcuni scrittori della “scuola dei duri”, in primo luogo Dashiell Hammett.
1943: chiude la rivista di John W. Campbell “Unknown Worlds”. 1949: Anthony Boucher, che ne era stato un attivo collaboratore, fonda insieme a J. Francis McComas una nuova testata che possa prenderne il posto e pubblicare, almeno in parte, lo stesso genere di materiale sofisticato sia nel campo della narrativa fantastica che della fantascienza; una rivista non più ritagliata nel classico formato pulp e che si rivolga ad un pubblico preparato, capace di recepire la science fiction moderna aperta alle suggestioni del mito. Il nuovo periodico, di formato digest o semi-tascabile, si intitola semplicemente “The Magazine of Fantasy”, anche se a partire dal secondo numero la testata verrà modificata in “The Magazine of Fantasy and Science Fiction”. Nel 2009 questa celebre pubblicazione americana – cui anche “Urania” deve molto, avendo attinto per anni ai suoi forzieri – ha festeggiato i sessant’anni di ininterrotta attività sotto la guida di Gordon Van Gelder. Boucher, il suo fondatore, l’aveva creata tenendo presenti due modelli: uno, come abbiamogià visto, è quello di “Unknown Worlds”, rivista in cui il fantastico non era mai gratuito né orripilante, ma rigoroso e vicino in spirito alla sf; l’altro è rappesentato da una pubblicazione gialla, la “Ellery Queen’s Mystery Magazine” (EQMM) che Frederic Dannay e Manfred B. Lee, i cugini Queen, avevano fondato per l’editore Mercury nel 1941. L’intento dei Queen era stato quello di creare una vetrina per il racconto giallo che non seguisse la moda della pulp fiction, ma permettesse ai migliori scrittori del poliziesco di trovare il proprio mercato anche al di fuori dell’indirizzo hardboiled. E così Rex Stout, Cornell Woolrich, John Dickson Carr e gli stessi Queen avevano potuto contare su uno sbocco nuovo e sofisticato, al quale ben presto si sarebbero accodati anche alcuni scrittori della “scuola dei duri”, in primo luogo Dashiell Hammett. 52 Comments »
52 Comments »
 Domanda: Vittorio, nei circa 50 anni di frequentazione della fantascienza in veste di autore, tu hai prodotto quasi esclusivamente opere brevi e brevissime. Lo testimonia, fra l’altro, la tua raccolta di racconti L’essenza del futuro edita nel 2007 da Perseo Libri, circa 650 pagine. L’unico tuo romanzo, finora, è stato Gli universi di Moras, che nel 1990 inaugurò la serie dei premi Urania. Come mai ora questo corposo volume, che solo un “Urania” Speciale ha potuto accogliere?
Domanda: Vittorio, nei circa 50 anni di frequentazione della fantascienza in veste di autore, tu hai prodotto quasi esclusivamente opere brevi e brevissime. Lo testimonia, fra l’altro, la tua raccolta di racconti L’essenza del futuro edita nel 2007 da Perseo Libri, circa 650 pagine. L’unico tuo romanzo, finora, è stato Gli universi di Moras, che nel 1990 inaugurò la serie dei premi Urania. Come mai ora questo corposo volume, che solo un “Urania” Speciale ha potuto accogliere?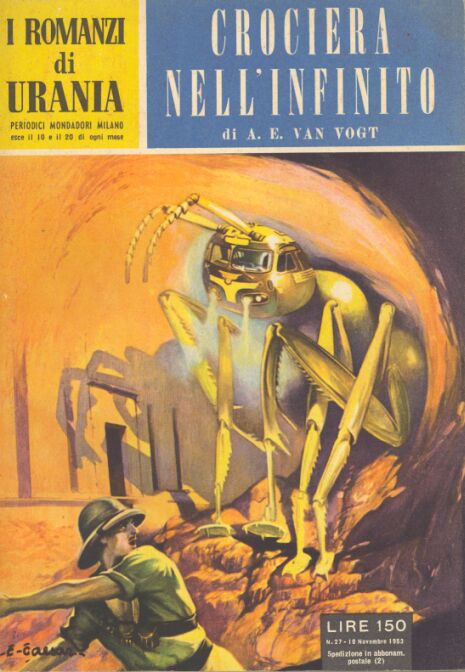

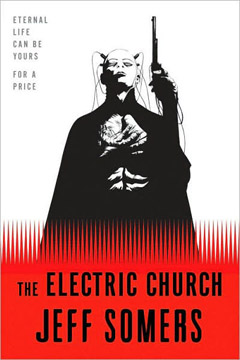 The Electric Church (2007) è un romanzo abbastanza singolare. Parte come la storia di un culto del futuro e si trasforma in una caccia all’americana di quelle che tante volte abbiamo letto nei classici hardboiled: una manhunt dove il cacciatore non è persona che incontreremmo volentieri tutti i giorni, ma che sicuramente potrebbe raccontarci qualche storia mozzafiato.
The Electric Church (2007) è un romanzo abbastanza singolare. Parte come la storia di un culto del futuro e si trasforma in una caccia all’americana di quelle che tante volte abbiamo letto nei classici hardboiled: una manhunt dove il cacciatore non è persona che incontreremmo volentieri tutti i giorni, ma che sicuramente potrebbe raccontarci qualche storia mozzafiato.  Walter S. Tevis
Walter S. Tevis Lino Aldani
Lino Aldani Modesto e sintetico,
Modesto e sintetico, 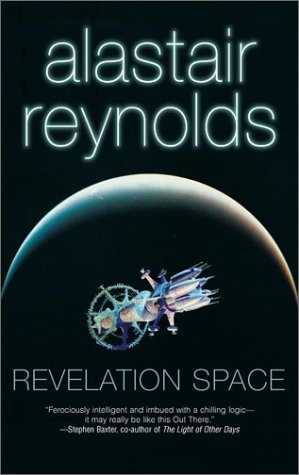 Come i lettori di questo romanzo vedranno, l’astronautica di Reynolds è veramente qualcosa che trascende i razzi di una volta, le “spazionavi” e l’overdrive abusée. Il titanismo degli scenari non è fine a se stesso e neppure la grandiosità dei meccanismi narrativi, che uniscono il fascino dell’ingegneria a quello, molto più morbido, delle civiltà perdute e dei misteri di archeologia spaziale. Più ancora del suo predecessore Peter F. Hamilton – a sua volta tradotto con successo da “Urania” – Alastair Reynolds sembra affascinato non soltanto dall’impresa in sé (l’esplorazione del cosmo), ma dalla sua componente epistemologica. Le domande che lo interessano, in Revelation Space, sono tutt’altro che banali, anzi sono le domande ultime: cosa ha generato l’universo? Quale piano si nasconde dietro l’ordine delle stelle? In questo la “Renaissance” della SF britannica si discosta di molte leghe dal gusto spettacolare dell’avventura cinematografica, restituendocene una visione altrettanto briosa eppure adulta.
Come i lettori di questo romanzo vedranno, l’astronautica di Reynolds è veramente qualcosa che trascende i razzi di una volta, le “spazionavi” e l’overdrive abusée. Il titanismo degli scenari non è fine a se stesso e neppure la grandiosità dei meccanismi narrativi, che uniscono il fascino dell’ingegneria a quello, molto più morbido, delle civiltà perdute e dei misteri di archeologia spaziale. Più ancora del suo predecessore Peter F. Hamilton – a sua volta tradotto con successo da “Urania” – Alastair Reynolds sembra affascinato non soltanto dall’impresa in sé (l’esplorazione del cosmo), ma dalla sua componente epistemologica. Le domande che lo interessano, in Revelation Space, sono tutt’altro che banali, anzi sono le domande ultime: cosa ha generato l’universo? Quale piano si nasconde dietro l’ordine delle stelle? In questo la “Renaissance” della SF britannica si discosta di molte leghe dal gusto spettacolare dell’avventura cinematografica, restituendocene una visione altrettanto briosa eppure adulta.
